

La messa in onda della prima serie, trasmessa dalla HBO tra il gennaio e il marzo del 2014, aveva consacrato True Detective come una delle serie più amate di sempre da pubblico e critica. Questa estate, la seconda stagione l’ha trasformata in una delle più discusse e criticate. Ma al di là dello speculare annullarsi di entusiasmi esagerati e bocciature senza appello, qual è il reale valore delle nuove otto puntate del serial?
 Dopo il successo planetario della prima stagione, contenitore di una delle serie più amate, citate e perché no parodiate nell’epoca della televisione digitale, la seconda annata di True Detective (d’ora in poi, TD 2.0) non è riuscita nell’impresa di ritrovare il consenso creatosi attorno alla precedente. Tuttavia, qualunque cosa si possa pensare delle nuove sceneggiature di Nic Pizzolatto, la pioggia di critiche con cui sono state accolte e, in ordine sparso, le accuse di lentezza, confusione, legnosità dei protagonisti, inutile moltiplicazione delle sottotrame, scarsa verosimiglianza, lacune narrative, proliferazione esasperata dei personaggi secondari, dispersione o, addirittura, ipocrisia moralista (secondo alcuni connaturata a una presunta «concezione negativa del sesso»), lasciano abbastanza perplessi, tanto da chiedersi se, in fondo, quanto si rimprovera a TD 2.0 non sia per caso il fatto di non essere un remake del prototipo targato 2014.
Dopo il successo planetario della prima stagione, contenitore di una delle serie più amate, citate e perché no parodiate nell’epoca della televisione digitale, la seconda annata di True Detective (d’ora in poi, TD 2.0) non è riuscita nell’impresa di ritrovare il consenso creatosi attorno alla precedente. Tuttavia, qualunque cosa si possa pensare delle nuove sceneggiature di Nic Pizzolatto, la pioggia di critiche con cui sono state accolte e, in ordine sparso, le accuse di lentezza, confusione, legnosità dei protagonisti, inutile moltiplicazione delle sottotrame, scarsa verosimiglianza, lacune narrative, proliferazione esasperata dei personaggi secondari, dispersione o, addirittura, ipocrisia moralista (secondo alcuni connaturata a una presunta «concezione negativa del sesso»), lasciano abbastanza perplessi, tanto da chiedersi se, in fondo, quanto si rimprovera a TD 2.0 non sia per caso il fatto di non essere un remake del prototipo targato 2014.
Si potrebbe anzi partire proprio da questo dato – la diversità rispetto alla prima stagione – per valutare serenamente pregi e difetti della nuova serie. Girata nelle pianure e nelle paludi della Louisiana meridionale, la “versione” inaugurale di TD immortalava il ritratto, intessuto di pessimismo filosofico e orrori contemporanei, di un Sud degli Stati Uniti gotico, sinistro, violento e superstizioso, pieno di contrasti lancinanti, patologie, perversioni e forme degenerate di integralismo religioso. Alla base di quello sceneggiato e, quindi, alla base dei contrasti tra i detective Marty Hart (tipico uomo del Sud, incarnato da Woody Harrelson, dal tratto virile, irascibile, donnaiolo, privo di dubbi e reazionario) e Rustin Cohle (lettore onnivoro e ateo disilluso in ragione delle passate sofferenze, con il volto smagrito e il nervosismo di Mattew McConaughey), c’era l’esperienza della realtà riportata da scrittrici come Flannery O’Connor e Katherine Ann Porter, o scrittori come William Faulkner e Tennessee Williams: la convinzione, cioè, che l’inferno esista e si materializzi nell’anima degli esseri umani, nell’arcaismo di un credo spirituale talmente rozzo da sconfinare in una sorta di bestiale paganesimo, persino dietro la facciata minacciosa del paesaggio, degli avvallamenti coperti da rampicanti, delle foreste di mangrovie così fitte da custodire intatta ogni goccia d’afa e ogni sfumatura di oscurità.
Merito della riuscita dell’opera andava senz’altro ascritto alla direzione istrionica di Cary Joji Fukunaga (tra qualche settimana dovrebbe uscire il suo Beasts Of No Nation, selezionato per il concorso del 72mo Festival di Venezia), regista unico di tutti e otto gli episodi, in grado di conferire all’intera stagione caratteristiche di uniformità anche in presenza di vere e proprie acrobazie come l’incredibile piano-sequenza di oltre 6’ nel finale della quarta puntata. Se affezionarsi ai luoghi, ai volti e ai protagonisti della prima serie era tutto sommato più semplice, anche perché il male veniva comunque «punito» (sebbene non sconfitto) e il rapporto tra i due personaggi principali, tornati a collaborare, dava luogo a una conclusione non solo positiva ma positivista (lo diceva lo stesso Cohle: Well, once there was only dark. If you ask me, light’s winning., «Una volta c’era solo il buio. Secondo me, la luce sta vincendo»), TD 2.0 sceglie invece di cancellare in partenza ogni possibile forma di empatia. I true detective di questa stagione inseguono i propri obiettivi non perché spinti dalla nobiltà della professione o dalla ricerca della verità, bensì a causa delle ossessioni personali da cui sono divorati, dei traumi più o meno recenti dai quali continuano a essere dilaniati.
Lo sfondo delle vicende non è più quello affascinante e ricco di colori della natura della Louisiana, ma il panorama anonimo di un luogo immaginario – la cittadina californiana di Vinci – modellata sui sobborghi di Los Angeles sporchi, corrotti e disperati dei romanzi di Charles Bukowski, Robert Maupin Beck (in arte Iceberg Slim), Kate Coscarelli, dove i poliziotti si aggirano privi di un traguardo morale (seppur primitivo come, lo scorso anno, l’idea di Hart d’impedire la trasformazione del mondo in a freakshow of murder and debauchery, «un baraccone di omicidi e dissolutezza») e, invece, soltanto arresi alla violenza, al bere, forse alla consapevolezza di non poter sciogliere del tutto i propri istinti peggiori, in una coreografia interiore di sofferenze ininterrotte, dentro una sensazione di prigionia rinchiusa in frasi smozzicate, dialoghi troncati, sussulti inghiottiti sul nascere.
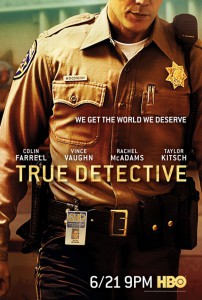 Su otto episodi complessivi, per confezionare la nuova stagione sono stati usati sei registi diversi, e benché le diverse mani siano a tal punto avvertibili da nuocere al ritmo generale dell’intera serie, in genere piuttosto blando, l’avvicendarsi dei punti di vista ha però consentito di far convivere l’originalità di certe idee con l’obbligo di tradurle in un linguaggio accessibile a tutti proprio perché serializzato, frammentario e rispettoso dell’intelligenza dello spettatore, al quale non è richiesto di tirare tutti i fili della trama né di soccombere a facili consolazioni.
Su otto episodi complessivi, per confezionare la nuova stagione sono stati usati sei registi diversi, e benché le diverse mani siano a tal punto avvertibili da nuocere al ritmo generale dell’intera serie, in genere piuttosto blando, l’avvicendarsi dei punti di vista ha però consentito di far convivere l’originalità di certe idee con l’obbligo di tradurle in un linguaggio accessibile a tutti proprio perché serializzato, frammentario e rispettoso dell’intelligenza dello spettatore, al quale non è richiesto di tirare tutti i fili della trama né di soccombere a facili consolazioni.
Church in ruins, la «cattedrale in rovine» del titolo sesto episodio di TD 2.0 (diventato, da noi, «Festa privata»), è la cittadina di Vinci, un piccolo centro molto industrializzato e altrettanto marcio, oggetto del desiderio di speculatori edilizi e popolato da funzionari dissoluti, criminali incalliti e tutori dell’ordine asserviti al tornaconto personale. Probabilmente ispirata alla reale Vernon (dieci chilometri a Sud di Los Angeles) e alle sue distese di asfalto e cemento, dove David Lynch ambientò Eraserhead, Vinci deve altresì tantissimo alla «città degli angeli» di alcuni romanzieri hard-boiled. Non quella marxista e rabbiosa di Dashiell Hammett, né quella del suo contraltare, l’esistenzialista e malinconico Raymond Chandler. La Vinci di TD 2.0 viene dritta dalle pagine aspre di James Ellroy, dal quale la serie prende anche gli intrighi complicatissimi tra malaffare e politica, e ne condivide il martellante credo secondo cui vizio, degrado e malvagità finiscono per contaminare ogni forma di virtù, a cominciare dall’amore e dall’etica professionale.
In TD 2.0, come appunto in Ellroy, o in Jim Thompson (senza dimenticare la descrizione, parziale ma esatta, dei rapporti tra sbirri, di certo debitrice dei lavori di Joseph Wambaugh), la decadenza e la corruzione della società riflettono la corrosione cancerosa dell’essere umano: ogni creatura è consumata dal suo trauma, e ognuno di questi contribuisce a delineare la condizione traumatica, cronica e irreversibile, della nazione tutta. Sebbene la serie prenda infatti le mosse dal ritrovamento del cadavere di un burocrate cittadino cui sono stati bruciati gli occhi con l’acido e maciullati i genitali, innescando così un’indagine in cui vengono coinvolti poliziotti venduti, papponi, un chirurgo estetico (tra l’altro interpretato dal musicista Rick Springfield, proprio il dottor Noah Drake di General Hospital), malviventi russo-israeliani, spacciatori, narcotrafficanti latinoamericani, proprietari terrieri, gestori di sale da gioco e persino il sindaco, le centinaia di ramificazioni politiche e sociali della trama si perdono quasi subito per strada, diluendosi, in un primo momento, in un affresco impressionante dell’amoralità di amministrazione e amministrati, e poi riverberando nelle storie private dei personaggi principali (ai quali toccherà scoprire come anche l’omicidio iniziale, anziché derivare da qualche astruso complotto delle alte sfere, sia riconducibile al desiderio di vendetta di un ragazzo cui tanti anni prima, assieme alla sorella, è stata rubata l’infanzia).
 Ray Velcoro (Colin Farrell) è un detective della polizia di Vinci, sovente soggiogato dalle autorità e dai farabutti locali, alla deriva da quando ha ammazzato (o almeno, così crede) chi gli ha violentato la moglie: il suo bambino, frequentato poco e male in seguito a una separazione ancora foriera di conflitti e tensioni, potrebbe essere figlio dello stupratore. Velcoro è l’informatore di Frank Semyon (Vince Vaughn), socio in affari del morto, cui aveva affidato milioni di dollari (volatilizzatisi) da investire: orfano di madre, in gioventù picchiato e segregato in cantina dal padre, Semyon vive ogni azione come una specie di rivalsa personale contro un destino di precarietà e ristrettezze che sente di non aver ancora scongiurato.
Ray Velcoro (Colin Farrell) è un detective della polizia di Vinci, sovente soggiogato dalle autorità e dai farabutti locali, alla deriva da quando ha ammazzato (o almeno, così crede) chi gli ha violentato la moglie: il suo bambino, frequentato poco e male in seguito a una separazione ancora foriera di conflitti e tensioni, potrebbe essere figlio dello stupratore. Velcoro è l’informatore di Frank Semyon (Vince Vaughn), socio in affari del morto, cui aveva affidato milioni di dollari (volatilizzatisi) da investire: orfano di madre, in gioventù picchiato e segregato in cantina dal padre, Semyon vive ogni azione come una specie di rivalsa personale contro un destino di precarietà e ristrettezze che sente di non aver ancora scongiurato.
Antigone “Ani” Bezzerides (Rachel McAdams), sceriffo della contea di Ventura, viene assegnata al caso per rimestare nella torbida palude socio-affaristica di Vinci: figlia del guru di una ex-comune degli anni ’70, da bambina è stata rapita e si presume abusata per quattro giorni da un individuo di cui non ricorda l’aspetto, diffida degli uomini, coi quali vive relazioni sessuali prive di implicazioni sentimentali, e ritiene che l’unica differenza tra i sessi stia nel fatto che one of them can kill the other with their bare hands («uno di essi può uccidere l’altro a mani nude»), perciò è diventata un’esperta nell’uso dei coltelli. Paul Woodrugh (Taylor Kitsch), agente della stradale, è cresciuto in un trailer con una madre alcolizzata (la rediviva, e ottima, Lolita Davidovich), ha operato da contractor in Afghanistan e, non riuscendo a tollerare la propria omosessualità, mette incinta una ragazza che non ama: alcuni poliziotti del dipartimento di Vinci tentano di ricattarlo con foto di un suo amplesso con un altro uomo.
Malgrado l’esibizione di quantità industriale di dettagli riguardanti documenti scottanti, opachi passaggi di proprietà, festini disinibiti per governatori e costruttori, piani segreti per incastrare procuratori generali e cartelli di criminalità messicana o est-europea, si capisce come TD 2.0 parli soprattutto dell’assenza dei padri e del dolore irreparabile dei figli, della mancanza di comunicazione (e della conseguente impossibilità di riscatto) tra i genitori e una prole spesso non desiderata, umiliata, messa al mondo per distrazione o vanità. Non esiste, nella serie, rapporto familiare slegato dal concetto di sopraffazione. Bezzerides detesta suo padre al punto da proiettarne la fisionomia sull’immagine incerta del suo rapitore, il morto della prima puntata potrebbe esser stato freddato da suo figlio, Woodrugh cerca un erede per compensare i vuoti interiori, il sindaco viene massacrato dai due figli, Semyon sente nella testa la voce del padre violento (e, forse a causa di una disfunzione erettile, non riesce a procreare), Velcoro vuole dare un ultimo saluto al figlio ma questo, nell’ultima puntata, lo porta nel mezzo di un’imboscata.
 A proposito di genitori assenti, ce n’è uno, invece, fin troppo presente, seppure in forma onirica (lo si vede anche in carne e ossa, in altre due occasioni, ma lo si può intuire abbastanza lontano dalla vita del figlio): all’inizio della terza puntata, dopo aver lasciato, nella precedente, Ray Velcoro a terra, preso a fucilate da qualcuno con indosso una maschera da corvo, lo vediamo discutere in un bar con uno sconosciuto, mentre un sosia di Elvis – unica altra presenza umana nel locale – intona i versi squillanti di The Rose, popolare canzone di Bette Midler rivisitata da Conway Twitty, in versione country, nel 1983. La parafrasi che ne ascoltiamo è piuttosto simile alla lettura di Twitty e, quindi, al classico schema country dell’amore descritto come fonte inesauribile di pena; in termini visuali, invece, tutta la scena, con i suoi neon morbidi, il buio quasi avvolgente e un’intensa tonalità di blu, sembra un omaggio evidente al David Lynch di Twin Peaks e Mulholland Drive.
A proposito di genitori assenti, ce n’è uno, invece, fin troppo presente, seppure in forma onirica (lo si vede anche in carne e ossa, in altre due occasioni, ma lo si può intuire abbastanza lontano dalla vita del figlio): all’inizio della terza puntata, dopo aver lasciato, nella precedente, Ray Velcoro a terra, preso a fucilate da qualcuno con indosso una maschera da corvo, lo vediamo discutere in un bar con uno sconosciuto, mentre un sosia di Elvis – unica altra presenza umana nel locale – intona i versi squillanti di The Rose, popolare canzone di Bette Midler rivisitata da Conway Twitty, in versione country, nel 1983. La parafrasi che ne ascoltiamo è piuttosto simile alla lettura di Twitty e, quindi, al classico schema country dell’amore descritto come fonte inesauribile di pena; in termini visuali, invece, tutta la scena, con i suoi neon morbidi, il buio quasi avvolgente e un’intensa tonalità di blu, sembra un omaggio evidente al David Lynch di Twin Peaks e Mulholland Drive.
I riferimenti possono apparire alti e seriosi, ma in realtà Velcoro – lo scopriremo più tardi – sta parlando con suo padre, un ex-poliziotto cui il figlio, benché reso «nervoso» dal trovarsi di fronte a lui, procura erba affinché il genitore possa dormire nonostante i problemi d’insonnia. Il padre, interpretato da un superlativo Fred Ward (qualcuno lo ricorderà in tanti film d’azione degli anni ’70 e ’80, o nel ruolo di Henry Miller per il poco riuscito Henry & June di Philip Kaufman), gli annuncia come morirà: crivellato dai proiettili, in un bosco. Quando Velcoro, nell’ultima puntata, sarà effettivamente ucciso dai suoi ex-colleghi in un fatale scontro a fuoco tra gli alberi, gli spettatori vedranno inquadrato il suo cellulare, scoprendo così che il messaggio vocale registrato dal piedipiatti per il figlio non ha fatto in tempo a caricarsi. Nessuno lo ascolterà mai: il piccolo e corpulento Chad Velcoro non sentirà le parole di suo padre poiché questi, a sua volta, non ha ricordato le parole trasmessegli in sogno da un padre altrimenti assente («I see you, running through the trees. You’re small. The trees are like giants. Men are chasing you. You step out the trees, you ain’t that fast. Now, son, they’ll kill you. Thet’ll shoot you in pieces»). Dietro la tragedia, l’umorismo nero, beffardo, sprezzante, quasi nichilista.
D’altronde, la frase campeggiante sulle locandine cartacee o digitali della serie è appunto We get the world we deserve («Abbiamo il mondo che ci meritiamo»), e l’entropia, l’insensatezza del mondo in cui viviamo non possono essere invertite, né ricomposte, da uomini e donne in fondo fragili, indifesi, succubi di fronte alle tentazioni e corrosi dal dolore. Non deve quindi stupire se il destino, in TD 2.0, si manifesta nelle sembianze di un commediante al vetriolo: le prostitute che i poliziotti sottraggono agli incontri, a base di sesso e stupefacenti, con i potenti della zona, non intendono affatto essere salvate, anzi se ne rammaricano. Nel momento in cui Semyon riesce a sfuggire alla vendetta dei messicani (aveva promesso loro di poter vendere sostanze illecite nei suoi locali, poi dati alle fiamme, in cambio di informazioni) consegnandogli un milione di dollari in contanti, questi lo accoltellano perché lui rifila un cazzotto al trafficante che pretende di avere il suo completo: You know, I didn’t wear a suit until I was 38 («Sai, non ho mai indossato un completo prima dei 38 anni»), sibila con rabbia prima di sferrare il colpo attraverso il quale si condannerà a morte, non riuscendo a reprimere l’antica rabbia del ragazzo di strada abusato, vessato e oggetto di bullismo. Il mondo come ce lo meritiamo: un universo testosteronico di violenza, coercizione e libidine sanguinaria (Everything is fucking, afferma a un certo punto una dolente Bezzerides, «tutto riguarda lo scopare»), dove tuttavia, con un sardonico ribaltamento dei ruoli, gli uomini sono condannati a morire e alle donne è invece affidata, dopo la sopravvivenza, la continuazione della specie.
Con un ulteriore contrappasso: ritrovare la propria umanità solo nella sofferenza. Jordan Semyon (Kelly Reilly), la moglie di Frank, riesce a soddisfare il suo desiderio di maternità solo surrogandolo (il piccolo non è suo) in un altro paese, in seguito alla morte del marito, e Ani Bezzerides – la madre del suddetto neonato – riesce a ricordare i giorni della sua segregazione, cancellando così anni di negazioni e oblìo autoimposto, solo partecipando, da infiltrata, a un festino in cui viene drogata e picchiata: la seconda è Maria, irredenta e non vergine, la prima è Maria Maddalena, discepola e testimone della nuova vita. Non so se Pizzolatto sia un individuo religioso, ma in queste considerazioni, nell’idea di una purificazione ottenibile attraverso le stazioni di un martirio, c’è il retaggio cattolico del Sud in cui è nato e cresciuto. E proprio la sua visione rigidamente autoriale rappresenta al tempo stesso l’aspetto più interessante e quello meno fluido dell’intera serie, in blocco somigliante a un’opera di Robert Bresson (grande regista francese e cattolico anomalo) trapiantata nei deserti di cemento e asfalto della California centrale: come Bresson, Pizzolatto si dimostra influenzato dal giansenismo (l’uomo, corrotto e calamitato dal male, può redimersi solo grazie all’intervento, concesso per predestinazione, della grazia divina), ma fino all’ultimo nega ai suoi protagonisti la salvezza, ovvero il tocco della grazia, confezionandogli addosso un melodramma freddo, spogliato da qualsiasi catarsi.
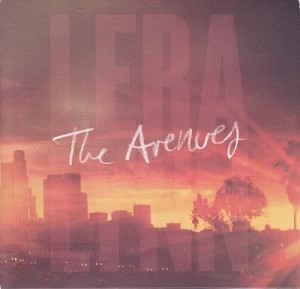 Un giansenismo di stampo bressoniano – si diceva – permea ogni fotogramma di TD 2.0, e nell’ultima puntata ciascuno dei protagonisti cade, in modo diverso, a terra, incapace di sorreggere il peso della propria croce. A confermare la natura, diciamo così, cristologica della serie provvede anche il cambio del tema musicale sui titoli di coda: al tetro hillbilly degli Handsome Family di Far From Any Road si sostituisce il Leonard Cohen di Nevermind, una preghiera (laica) sulla crudeltà feroce della Storia sgranata sopra un recitativo in lingua inglese e araba. E anche le canzoni disseminate lungo gli episodi, in una colonna sonora ancora una volta supervisionata dall’esperto T-Bone Burnett, sono (con la vistosa eccezione di una sequenza in cui Velcoro si sbronza e tira di coca al ritmo delle New York Dolls di Human Being) quasi tutte affidate alle fragili, drammatiche ballate (due di queste scritte a quattro mani con Rosanne Cash) in cui Lera Lynn – la cantante del bar dove s’incontrano Velcoro e Semyon – dispiega le proprie metafore del suicidio (vi consiglio di recuperare il suo secondo album, The Avenues [2013], stupenda raccolta, autoprodotta e distribuita in proprio, di esemplari country-folk tra gli ipnotici affreschi rootsy di Gillian Welch e le cantilene catacombali di Nico). La musica, in TD 2.0, svolge un ruolo importante, di dialogo e integrazione con le immagini, secondo i dettami di un artificio retorico portato alla massima efficacia dal Martin Scorsese degli anni ’70 (e in seguito da questi ripreso, con inalterata e forse superiore incisività, perlomeno in Quei Bravi Ragazzi e Casinò).
Un giansenismo di stampo bressoniano – si diceva – permea ogni fotogramma di TD 2.0, e nell’ultima puntata ciascuno dei protagonisti cade, in modo diverso, a terra, incapace di sorreggere il peso della propria croce. A confermare la natura, diciamo così, cristologica della serie provvede anche il cambio del tema musicale sui titoli di coda: al tetro hillbilly degli Handsome Family di Far From Any Road si sostituisce il Leonard Cohen di Nevermind, una preghiera (laica) sulla crudeltà feroce della Storia sgranata sopra un recitativo in lingua inglese e araba. E anche le canzoni disseminate lungo gli episodi, in una colonna sonora ancora una volta supervisionata dall’esperto T-Bone Burnett, sono (con la vistosa eccezione di una sequenza in cui Velcoro si sbronza e tira di coca al ritmo delle New York Dolls di Human Being) quasi tutte affidate alle fragili, drammatiche ballate (due di queste scritte a quattro mani con Rosanne Cash) in cui Lera Lynn – la cantante del bar dove s’incontrano Velcoro e Semyon – dispiega le proprie metafore del suicidio (vi consiglio di recuperare il suo secondo album, The Avenues [2013], stupenda raccolta, autoprodotta e distribuita in proprio, di esemplari country-folk tra gli ipnotici affreschi rootsy di Gillian Welch e le cantilene catacombali di Nico). La musica, in TD 2.0, svolge un ruolo importante, di dialogo e integrazione con le immagini, secondo i dettami di un artificio retorico portato alla massima efficacia dal Martin Scorsese degli anni ’70 (e in seguito da questi ripreso, con inalterata e forse superiore incisività, perlomeno in Quei Bravi Ragazzi e Casinò).
 La colonna sonora – un’antologia dei brani affiorati in entrambe le stagioni – uscita pochi mesi fa col titolo di True Detective – Music From The HBO Series (Harvest/Universal), presenta quattro brani dalla prima serie, ossia i citati Handsome Family, la Cassandra Wilson raccolta e bluesy di Sign Of The Judgement, il Bob Dylan cupo e millenarista di Rocks And Gravel, il Father John Misty folkie e idilliaco della sintetica The Angry River, e dieci dalla seconda. Cinque appartengono al repertorio della Lynn, mentre le rimanenti, dal folk-rock elettrico, sferzante e composto per l’occasione da Nick Cave e Warren Ellis (All The Gold In California) al countreggiare desolato di Bonnie “Prince” Billy (Intentional Injury), dalle spettrali pose à la Elvis di John Paul White (What A Way To Go) alla suddetta traccia di Cohen, hanno il compito non tanto di illustrare il contenuto musicale di TD 2.0, bensì di mostrare, ricorrendo a un’atmosfera unanime di oppressione e avvilimento, come il suono possa frammentare e ricomporre i temi della sceneggiatura.
La colonna sonora – un’antologia dei brani affiorati in entrambe le stagioni – uscita pochi mesi fa col titolo di True Detective – Music From The HBO Series (Harvest/Universal), presenta quattro brani dalla prima serie, ossia i citati Handsome Family, la Cassandra Wilson raccolta e bluesy di Sign Of The Judgement, il Bob Dylan cupo e millenarista di Rocks And Gravel, il Father John Misty folkie e idilliaco della sintetica The Angry River, e dieci dalla seconda. Cinque appartengono al repertorio della Lynn, mentre le rimanenti, dal folk-rock elettrico, sferzante e composto per l’occasione da Nick Cave e Warren Ellis (All The Gold In California) al countreggiare desolato di Bonnie “Prince” Billy (Intentional Injury), dalle spettrali pose à la Elvis di John Paul White (What A Way To Go) alla suddetta traccia di Cohen, hanno il compito non tanto di illustrare il contenuto musicale di TD 2.0, bensì di mostrare, ricorrendo a un’atmosfera unanime di oppressione e avvilimento, come il suono possa frammentare e ricomporre i temi della sceneggiatura.
True Detective – Music From The HBO Series, insomma, non pretende di essere “completo”; altrimenti avrebbe dovuto raccogliere, dalla prima stagione, i contributi di Kinks, Steve Earle, Lucinda Williams, Black Angels, John Lee Hooker, Vashti Bunyan, 13th Floor Elevators, Buddy Miller, Johnny Horton, Dwight Yoakam, Kris Kristofferson, Waylon Jennings, Meredith Monk, Emmylou Harris, BRMC, Townes Van Zandt, Richard & Linda Thompson, Bo Diddley, Melvins, Wu-Tang Clan, Slim Harpo etc., e dalla seconda, se non altro, i Raveonettes di Kill! (dal secondo episodio), il Warren Zevon di Detox Mansion (dal terzo) o i Blind Faith di Can’t Find My Way Home (dal quarto, quando Woodrugh chiede alla sua ragazza di sposarlo). Il compito che il disco si prefigge, e nel quale riesce, è quello di testimoniare come la complessità e la varietà della tessitura sonora possano riflettere la concezione e il contesto emotivo dell’intero progetto, dove le sovrapposizioni e gli incroci proposti dallo studiatissimo missaggio propongono un equivalente acustico della percezione visiva.
In ultimo va aggiunto come il clima di pessimismo cosmico, assoluto e dilagante, reso evidente persino dalla recitazione volutamente catatonica degli attori, ognuno di loro impegnato a parlare attraversi timbri così strascicati e faticosi da lasciar supporre difficoltà respiratorie, non trovi però, come detto, alcuno sfogo, nessuna catarsi melodrammatica o violenta. Malgrado gli scoppi di violenza non manchino (difficile dimenticare le immagini in cui Semyon prende in mano una tenaglia per staccare dalle gengive i denti d’oro di un pappone) e parimenti si dispieghi il melodramma (risponde alle regole del genere, per esempio, il momento dell’apertura della busta contenente gli esiti del test di paternità da parte dell’ex-moglie di Velcoro), nessuno dei due risulta liberatorio. Le emozioni, proprio come in un film di Bresson, vengono trattenute, sempre, e dissipano i personaggi dall’interno.
È la scelta del Pizzolatto “autore”, deciso a imprimere la propria impronta fino in fondo, talvolta a discapito della coerenza del racconto d’insieme e dell’efficacia di alcune rivelazioni in teoria determinanti (vedi la possibile paternità dei fratelli Osterman, altro caso da manuale di incubo edipico). Ecco, insomma, che TD 2.0 funziona senza intoppi come prodotto d’autore, allineando in piena luce tutti gli elementi utili a sottolineare il tocco del suo creatore, e un po’ meno come prodotto seriale, in parte compromesso dall’eccedenza di estensioni narrative appena sfiorate e un secondo dopo buttate via. Analogamente rigoroso appare lo stile visivo, di nuovo sensibile a qualche rimando all’universo di David Lynch (più citato, comunque, nella prima serie) e somigliante, soprattutto nella sparatoria assordante e realistica (con inseguimento a piedi successivo all’esplosione di un laboratorio di droghe sintetiche) del quarto episodio, a una rilettura, spogliata di ogni accento epico, del William Friedkin bruciato dal sole di Vivere E Morire A Los Angeles.
C’è spazio anche per un richiamo a Viale Del Tramonto (nel corpo del sindaco Austin Chessani che galleggia, senza vita, in una piscina, inquadrato da dentro l’acqua come il William Holden del film di Billy Wilder), ma si tratta di un omaggio estemporaneo e in fondo ininfluente a una delle pellicole più cupe e sferzanti di sempre sul divismo hollywoodiano. Per il resto, sebbene il montaggio ipotattico dell’ultima puntata configuri un vero e proprio esercizio di virtuosismo, nessun cedimento a tentazioni spettacolari, solo l’inseguimento stilizzato, tagliente e severo della deriva inesorabile di un pugno di (anti)eroi solitari, silenziosi, uniti dal destino per aprire un’ennesima porta sul buio dell’animo umano. Perfino nelle scene più accese, dal pestaggio inflitto a Semyon nel deserto (dove la luce accecante frantuma profili e volumi) allo scontro a fuoco, nei sotterranei oscuri della città, tra gli uomini della Black Mountain e Woodrugh (che ne uscirà cadavere) mentre la compagna di questi, incinta di lui, si commuove guardando in tv Natalie Wood, diretta da Elia Kazan in Splendore Nell’Erba, ogni ripresa viene sottoposta a un controllo formale impeccabile, in modo da mettere insieme una rappresentazione quasi liturgica della tortura compiuta dagli esseri umani sui propri simili, la messa in scena accorata delle decine di rifrazioni – gli abusi familiari, l’emarginazione, le psicosi, i fantasmi del passato – della sofferenza tra creature. Pizzolatto non si interroga sul senso del male, come possono in precedenza aver fatto cineasti quali Abel Ferrara o Michael Haneke (oppure ancora, in ambito romanzesco, Harold Pinter o lo svizzero Friedrich Dürrenmatt). Lo dà per scontato, lo osserva con sguardo cupo e disincantato, immerso in un estenuante grigiore: così i suoi personaggi, intrappolati nelle gabbie dei propri desideri irrealizzabili seppur privi del coraggio, della pulizia, dell’amore e della fede necessari a spezzarle. Ancorché elementare, la più volte richiamata etica di TD 2.0 è scontata solo a condizione di ignorarne l’evidenza quotidiana. «Abbiamo il mondo che ci meritiamo»: e non gli umili, ma i più disumani e spietati, erediteranno la terra. Se non l’hanno già fatto.