
 Waxahatchee – Foto: Lino Brunetti
Waxahatchee – Foto: Lino Brunetti Non occorre condividere tutte le istanze del movimento #metoo, campagna contro le molestie sessuali presto diventata battaglia femminista a più ampio raggio (e come tutte le battaglie non esente da semplificazioni o eccessi di correttezza politica), per rendersi conto di quanto il rapporto tra donne e musica sia ancora succube di pregiudizi dei quali sarebbe opportuno disfarsi con una certa fretta. Basta pensare a come un glorioso produttore del calibro di Jimmy Iovine, ieri collaboratore della Patti Smith di Easter (1978) o del Tom Petty di Damn The Torpedoes (1979), oggi nella direzione amministrativa di Apple Music, abbia pensato di pubblicizzare il servizio di streaming offerto dall’azienda, e cioè sottolineandone la praticità soprattutto per «le ragazze», secondo lui necessitanti di trovare musica quando «siedono insieme, parlando di ragazzi, e lamentandosene se sono preda di una qualche delusione sentimentale». Di una stupidaggine simile, per fortuna, Iovine si è scusato,ma non è il solo a non essersi accorto, a quanto sembra, del fatto che alcuni dei migliori dischi degli ultimi anni siano stati pensati, eseguiti e prodotti da donne. Sebbene la musica, rispetto a altri settori, abbia negli anni manifestato un buon numero di difese immunitarie contro le discriminazioni di genere (si guardi alla grande stima di cui hanno sempre goduto, tra le altre, Aretha Franklin, Joni Mitchell, Joan Baez, Carole King, Nina Simone, Stevie Nicks, Kate Bush, Tina Turner, Diana Ross, Loretta Lynn, Dolly Parton, Rickie Lee Jones, Emmylou Harris, Ella Fitzgerald, Chrissie Hynde, Pauline Black, Debbie Harry, Poly Styrene, Siouxie Sioux, Viv Albertine, Nico, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, Miriam Makeba, Cassandra Wilson, Joan Jett e le Runaways, Laurie Anderson, Tammy Wynette, Astrud Gilberto, Laura Nyro, Bobbie Gentry, Roberta Flack, Janis Ian, Buffy Sainte-Marie, Umm Kulthum, Sandy Denny, Mercedes Sosa, Dusty Springfield, Marianne Faithfull, Kim Gordon e centinaia d’altre), sono senz’altro cambiati i tempi in cui, davanti a un album di Lucinda Williams, Shelby Lynne, Fiona Apple, Sheryl Crow, Indigo Girls, Björk, Dixie Chicks, Tracy Chapman, Gillian Welch, Liz Phair, Tori Amos, Ani DiFranco, PJ Harvey o Michelle Shocked (quest’ultima davvero finita malissimo), se ne enfatizzava all’istante l’appartenenza di genere. Perché la musica non è fatta da uomini, per gli uomini; appartiene a tutti. E a tutti appartengono i quindici dischi — non «al femminile», solo dischi — che vi consigliamo qui.
 chi: MEG BAIRD
chi: MEG BAIRD
dove: San Francisco, California
cosa: Dear Companion (Drag City, 2007)
Un tempo occupata a ricamare la psichedelia hippie degli Espers, tuttora membro degli stonatissimi (nel senso delle droghe assunte, come da copione heavy-psych) Heron Oblivion, Meg Baird insegue dal 2007 una carriera solista legata alla tradizione del folk britannico, raccontando cioè di raggi di sole bagnati dalla pioggia, prati verdeggianti a perdita d’occhio e arcadici paesaggi di campagna con l’assorta dolcezza di Sandy Denny. Tre dischi fino a oggi, tutti riusciti , ma l’onirica delicatezza del primo Dear Companion, poema autunnale appeso al lirismo straordinario di una All I Ever Wanted (New Riders Of The Purple Sage) di rara bellezza e a diversi e incantevoli omaggi all’arte inarrivabile dei Fairport Convention (senza dimenticare il dulcimer di Sweet William And Fair Ellen, o le armonie celestiali di Maiden In The Moor Lay), resta a suo modo unico.
chi: PIETA BROWN
dove: Iowa City, Iowa
cosa: Postcards (Lustre, 2017)
In Street Tracker c’è la chitarra di Mark Knopfler, in Stopped My Horse la voce di Carrie Rodriguez, su In The Light il classico diorama dal deserto dei Calexico, ma Postcards è soprattutto il disco in cui Pieta Brown, al suo settimo lavoro, si affranca dall’influenza illustre di padre (Greg Brown) e marito/produttore (Bo Ramsey) per lasciare le proprie canzoni libere di svilupparsi sopra una prateria cosmica e stellare, dove l’orizzonte del sogno e la linea ruvida della terra si incontrano di continuo. Cartoline da un’altra America fatta di strade perdute, case mobili sistemate nell’alveo scomodo della provincia, tavole calde fluttuanti in una prospettiva resa febbricitante dai riverberi del sole sull’asfalto, l’album seduce con una grazia lineare e misteriosa, compiendo il piccolo miracolo di esprimere con semplicità i sussulti interiori della sua autrice.
 chi: CAYETANA
chi: CAYETANA
dove: Philadelphia, Pennsylvania
cosa: Nervous Like Me (Tiny Engines, 2014)
Punk-rock sbilenco e spesso stonato, in un’ottica stracciona nella quale sopraggiungono i nomi di Speedy Ortiz, Kurt Vile o Swearin’, e più ancora di tutti questi pur dignitosi epigoni, l’eco del re inarrivabile dei naïf, ossia Jonathan Richman. Filastrocche infantili e cantilene adolescenziali, satire bonarie della vita sulla strada (Scott Get The Van, I’m Moving), patafisica kitsch, parentesi di ineffabile nostalgia (in Favorite Things sembra persino di ascoltare Paul Simon) e selvatico folk di strada sono gli ingredienti del debutto delle Cayetana dopo l’interesse suscitato dal 7 pollici Hot Dad Calendar, uscito nei primi mesi dello stesso anno. Per quanto spontanea, la zoppicante naturalezza di Augusta Koch, Allegra Anka e Kelly Olsen conserva un naturale retrogusto amaro, come se i loro rimandi agli anni ’50 schermassero una critica sotterranea alle frivole mondanità del mondo contemporaneo.
chi: JEN CLOHER
dove: Melbourne, Victoria
cosa: Jen Cloher (Milk! Records, 2017)
Debuttante nel 2006, con la sua band di allora (Endless Sea), l’australiana Jen Cloher, spesso collaboratrice di Courtney Barnett (le due sono sposate), riporta tutto a casa con un secondo album solista (ce n’era stato un primo, In Blood Memory, nel 2013) ispirato ai conterranei Triffids di Born Sandy Devotional (1986) nel redigere un omaggio ai panorami della sua terra, immortalata attraverso la lente dei sentimenti. Non si pensi, però, nonostante la copertina spoglia, a un catalogo intimista (pur infoltito dalla cupa analisi interiore di Dark Art o Sensory Memory), perché durante Shoegazers, in mezzo a un diluvio di schitarrate stonesiane, sembra di trovarsi di fronte alla Patti Smith di Rock And Roll Nigger (in occasione dei 40 anni di Horses, scoccati nel 2015, Cloher ha difatti saputo portare in scena una Land quasi più scatenata e oltraggiosa del prototipo), il marasma di distorsioni in Strong Woman strizza l’occhio a PJ Harvey e le cadenze ipnotiche di Regional Echo evocano la psichedelia rockista dei Dream Syndicate. Se dovete comprare un solo disco tra quelli compendiati in questo articolo, procedete con Jen Cloher.
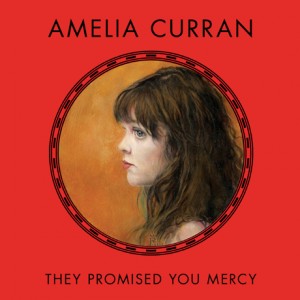 chi: AMELIA CURRAN
chi: AMELIA CURRAN
dove: Halifax, Nuova Scozia
cosa: The Promised You Mercy (Six Shooter, 2014)
Cresciuta nella venerazione di Leonard Cohen, peraltro spesso citato in modo più o meno diretto nei suoi testi, Amelia Curran è abituata a sovrapporre sussurri jazz e introspezione folkie nel disegno di scenografie minimaliste leggere e sfuggenti come cristalli di neve. Nel settimo They Promised You Mercy, però, le ambizioni dell’autrice si concretizzano in una dimensione rockista di taglio classico, annunciata sin dall’organo rutilante dell’iniziale Somebody Somewhere e dal “tiro” power-pop della grintosa Never Say Goodbye. Le fantasmagorie invernali del passato non sono scomparse (ascoltate la desolata Time, Time) ma si inseriscono alfine in un contesto più completo e personale, dove la tristezza ineffabile dell’amore assente sa tradursi anche tramite batterie in fibrillazione e fiati dall’incedere selvatico.
chi: LAURA GIBSON
dove: Coquille, Oregon
cosa: La Grande (Barsuk, 2012)
Con una formazione da violoncellista classica alla spalle, Laura Gibson è arrivata a La Grande, suo terzo album (a cui per ora ha fatto seguito, nel 2016, solo un altro lavoro) proponendo miniature semiacustiche in apparenza amatoriali di country, swing, folk e vecchie canzoni d’amore. Un po’ k.d. lang, un po’ Patsy Cline, dietro l’apparente svagatezza Gibson nasconde con adorabile ritrosia il rigore e la disciplina necessaria a interpretare valzer polverosi e ballate d’altri tempi, raccontando di frenesie sessuali e rapporti orali neanche troppo metaforizzati. Stilista della malinconia dai toni seppia , l’artista dà il meglio di sé nel carillon in disfacimento di Red Moon, brano dove Bob Wills e Tito Puente, per quanto strano possa sembrare, si offrono un bicchiere di quello buono nel medesimo saloon.
 chi: JADE JACKSON
chi: JADE JACKSON
dove: Santa Margarita, California
cosa: Gilded (An -, 2017)
Voce possente e caratteristica, echi di frontiera, l’inquietudine di un bagaglio tradizionale riletto in uno schianto tra le melodie degli Smiths e il punk-blues urticante dei Gun Club: la giovanissima Jade Jackson, non a caso presieduta da un produttore di vaglia come Mike Ness dei Social Distorsion, vince tutto con un Gilded che, seppur sottovalutato dalla critica, stabilisce un parallelo con la collega Lydia Loveless nel rileggere il folclore sonoro degli States con rabbia, sfacciataggine e veleno femminista. Il rock’n’roll di Good Time Gone, la cavalcata al tramonto di una Troubled End galoppante tra Johnny Cash e Nikki Sudden, gli scossoni elettroacustici con cui vengono rivisitate le radici di Bridges e Back When, in una tempesta rabbiosa di eccessi e sei corde, regalano nuova linfa al filone cow-punk così come l’abbiamo conosciuto dagli ’80 in poi.
chi: LYDIA LOVELESS
dove: Columbus, Ohio
cosa: Somewhere Else (Bloodshot, 2014)
«Verlaine sparò a Rimbaud perchè lo amava così tanto», canta Lydia Loveless nel suo terzo e migliore album, un’ubriacante istantanea elettrica, tra sbronze country e fracasso alla Replacements, di un mondo dove amore e ossessione assomigliano alla stessa cosa e i rapporti tra esseri umani soggiaciono a un’irrefrenabile cupidigia sessuale. Si rincorrono Wine Lips da baciare e succhiare, si prega il compagno (accade in Head) di non interrompere una prestazione sessuale, si cita il desiderio bruciante della Lucinda Williams di I Just Wanted To See You So Bad (in Really Wanna See You Again) e soprattutto si fanno sposare power-pop, country-punk e roots-rock sferragliante in dieci brani dall’impeto passionale e irriverente come la musica delle radici, troppo spesso, non sa o non vuole più essere.
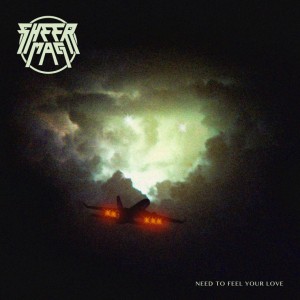 chi: SHEER MAG
chi: SHEER MAG
dove: Philadelphia, Pennsylvania
cosa: Need To Feel Your Love (Wilsuns/Static Shock, 2017)
La corpulenta Tina Halladay trascende ogni cliché — di linea, di avvenenza, di estensione vocale — relativo alle cosiddette donne rock. Il fatto che i suoi Sheer Mag, dopo tre extended omonimi, giungano al debutto sulla lunga distanza con un disco dove, in mezzo al solito arsenale di metallo dalle sfumature glam, rock stradaiolo, inchini alla turbolenza dei Thin Lizzy e proiettili chitarristici di cui persino gli Hold Steady si sarebbero (forse) vergognati, si estrinseca la volontà di ricordare Sophie Scholl — promotrice della resistenza tedesca al nazismo d’ispirazione cristiana — quale simbolo dell’allergia ai luoghi comuni femministi (o anti-femministi, non cambia nulla) anche oggi così in voga, è solo uno dei motivi per i quali Need To Feel Your Love risulta essere tra gli album a un tempo più passatisti e contemporanei di tutto il 2017.
chi: SHILPA RAY
dove: Brooklyn, New York
cosa: Last Year’s Savage (Northern Spy, 2015)
Primo album lungo di una mezzosangue del New Jersey refrattaria alle categorie, Last Year’s Savage sembra davvero il prontuario della musicista squattrinata e sognatrice, cresciuta nel minestrone di razze, tradizioni e antropologie della costa orientale e da lì debuttante con un trattato per nulla modaiolo di canzoncine blues, di quel blues dell’anima — un fatto di spirito e non di forma — come potevano appunto intenderlo Alex Chilton o Alan Vega, tutte arrangiate con estrema classe (solo in apparenza casuale) e attraversate da una vena anarcoide, poveristica e spiazzante in grado di renderle simpatiche dal primo ascolto. Shilpa Ray mette sul piatto una voce inconfondibile, somigliante a un incrocio tra la fissità catacombale di Nico e la viscerale, squillante emotività di Patti Smith, una serie di brani consacrati agli argomenti più improbabili (Sanitary iPad viene raccontata dalla prospettiva di un tablet cosciente della propria obsolescenza precoce), un continuo flusso di citazioni prelevate dall’immaginario gommoso e cromato dell’America di sessant’anni fa, tonnellate di umorismo nero e una vena gotica abbastanza pronunciata, sempre serpeggiante benché adoperata con immancabile ironia. Risultato spiazzante, originale, innovativo.
 chi: LAURA STEVENSON
chi: LAURA STEVENSON
dove: Long Island, New York
cosa: Cocksure (Don Giovanni, 2015)
Figlia di un pianista e di una musicista jazz, attivissima nello stesso circuito indipendente da cui è emerso Jeff Rosenstock, Laura Stevenson aggredisce la pedaliera della chitarra e la bella forma delle classiche melodie power-pop con la stessa sporcizia, lo stesso tocco ruvido appartenuto a Juliana Hatfield e Nina Gordon. O almeno lo fa nel quarto Cocksure, cornucopia di petardi pop-punk fatti esplodere con l’abbandono e l’irruenza grungy di chi vuole lasciarsi alle spalle il puro cantautorato del precedente Wheel (2013), peraltro altrettanto micidiale e compatto benché afferente a un diverso linguaggio. Qui, invece, nei riff graffianti di Jellyfish o Out With A Whimper, e così pure nel gran finale elettrico di Tom Sawyer / You Know Where You Can Find Me, si piange e si poga come se non ci fosse un domani.
chi: SUSANNE SUNDFØR
dove: Oslo, Norvegia
cosa: Music For People In Trouble (Bella Union, 2017)
Piccola celebrità di quella Norvegia di cui è originaria, in passato collaboratrice di Madrugada, Tom McRae, Jaga Jazzist, Nils Petter Molvær, M83 e Röyksopp, Susanne Sundfør è riuscita, con cinque album dal 2007 a oggi, a muoversi in ambiti anche molto diversi tra loro — dream-pop, musica classica, ambient, elettronica e jazz — senza lasciarsene fagocitare da nessuno. Music For People In Trouble, nato dall’esigenza di tornare a confrontarsi con sonorità minimali e in massima parte acustiche dopo tanti anni passati a braccetto con le tecnologie più avanzate, e soprattutto scaturito da un esaurimento nervoso a sua volta foriero di un lungo periodo di depressione, segnala infatti, con le sue rarefazioni folk e la sua eleganza cameristica, l’ennesimo cambio di direzione da parte di un artista il cui traguardo più importante, a quanto sembra, è quello di non ripetersi.
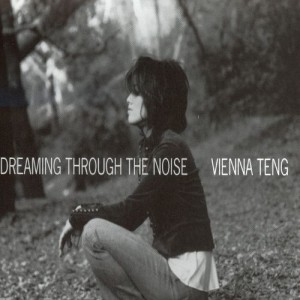 chi: VIENNA TENG
chi: VIENNA TENG
dove: Saratoga, California
cosa: Dreaming Through The Noise (Zoë, 2006)
Terzo album della cantautrice taiwanese-americana, Dreaming Through The Noise è il lavoro in cui Vienna Teng (in seguito un po’ sbiadita) meglio delinea, grazie anche alla sapiente produzione di Larry Klein, un bruciante, solitario matrimonio tra austerità folk, melodie pop e indimenticabili divagazioni jazz, fino a far apparire ancora irripetibile l’intreccio di trombe e chitarre della stupenda Recessional. Nello struggimento notturno di Transcontinental, 1:30 AM, nella rarefatta tristezza di una Nothing Without You con pianoforte alla Tori Amos o nel folk-jazz sincopato di 1BR/1BA non si rimpiange la Joni Mitchell della seconda metà dei ’70 e, aggiunte al carico le meraviglie classicheggianti di Now Three e il manifesto di orgoglio gay della composta ballata pop City Hall, scusate se è poco.
chi: WAXAHATCHEE
dove: Birmingham, Alabama
cosa: Cerulean Salt (Don Giovanni, 2013)
Da un’infanzia trascorsa sulle strade dell’Alabama e lungo l’argine del Waxahatchee Creek, Cerulean Salt, secondo album di Katie Crutchfield dietro lo pseudonimo di Waxahatchee, rappresenta il distacco, il lungo addio preposto a lasciare campo a una sofferta maturità. Inizio per voce e chitarra, con la spettrale ruminazione di Hollow Bedroom, e prosecuzione imprevedibile con le nuvole di riverbero attraversate in Misery Over Dispute e il disastro percussivo della fulminante Coast To Coast: Crutchfield racconta la perdita, l’abbandono e il disagio esistenziale con un senso d’intimità quasi insostenibile nel suo dispiegarsi. Il dondolante tremolio folkie della fragile Blue Pt. II (indovinate voi a chi sia ispirata) suona nello stesso momento come un saluto affettuoso, seppur rattristato, e una salubre dimostrazione di modestia.
 chi: THE WEATHER STATION
chi: THE WEATHER STATION
dove: Toronto, Ontario
cosa: The Weather Station (Paradise Of Bachelors, 2017)
Per la canadese Tamara Lindeman, meglio nota come Weather Station, il quarto e omonimo album — autoprodotto, meglio impostato e più personale dei predecessori — rappresenta una dichiarazione d’intenti. Femminismo, omaggi a Joni Mitchell e Joy Division, confessioni a cuore aperto («Non so cosa dire / quindi dico troppo»), arpeggi toccanti delle chitarre, il velluto morbido e discreto di una sezione d’archi mai troppo invadente, piccole scosse elettroacustiche simili, nell’ambito della parafrasi, alla traduzione di Van Morrison eseguita dal collega Ryley Walker: il pianoforte di The Most Dangerous Thing About You, lo snervante serpente elettrico di Complict e la fuggevole quiete interiore di You And I (On The Other Side Of The World) racchiudono la più emozionante celebrazione del folk-rock anni ’70 ascoltata di recente.
bonus-track
chi: ONE OF THE BOYS
dove: Minneapolis, Minnesota
cosa: Pinned Up (Movement Records, 2013)
Nel mettere insieme questa antologia di nomi non è stato seguito alcun criterio se non quello di scegliere artiste indipendenti, di proposito lasciando fuori nomi (anche meritevoli, da Brandi Carlile a Margo Price, da Tift Merritt a Miranda Lambert) nel frattempo transitate su major o comunque non estranee all’ambito delle multinazionali. Tina Schlieske non dovrebbe rientrare nella cernita perché, oltre a essere stata sotto contratto presso la Warner Bros. nei ’90, si aggira ormai sui palcoscenici da quasi trent’anni. Eppure, dopo i sottovalutati Tina & The B-Side Movement (ragione sociale rispolverata giusto due stagioni fa), dopo i dischi solisti e dopo uno strambo album natalizio accreditato a Lola & The Red Hots, la cantante ha trovato pure il tempo per mettere in piedi un estemporaneo progetto a nome One Of The Boys, nel 2013 responsabili di un EP dedicato alle canzoni di altri conterranei anche loro provenienti dal Minnesota. Pinned Up è una di quelle curiosità destinate a essere fagocitate dall’inclemenza del tempo (potete acquistarlo dal sito dell’artista, ma già su Discogs risulta irreperibile), eppure la malinconia, il trasporto accorato, le dolenti finiture jazz, le tinte crepuscolari e la dolente vitalità con cui Schlieske vi rilegge The Game (Soul Asylum), Makes No Sense At All (Hüsker Dü), Most Of The Time (Bob Dylan), Big Star (Jayhawks), When Doves Cry (Prince) e Sixteen Blue (Replacements) non hanno nulla da invidiare al gusto narrativo di un grande romanziere, capace di cogliere, nello spazio ristretto di sei capitoli appena, tutto il senso di emarginazione e il lirismo generazionale di un’adolescenza trascorsa specchiandosi nelle note altrui, affidando il proprio dolore a una loro sequenza, fronteggiando l’inverno dell’anima tramite le manopole dello stereo.