

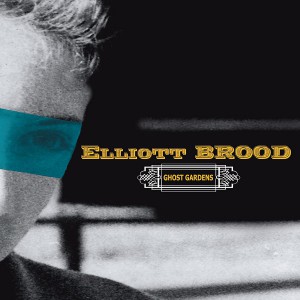 ELLIOTT BROOD
ELLIOTT BROOD
Ghost Gardens
Paper Bag
***
Un po’ come in un quadro di Jackson Pollock, nei dischi degli Elliott Brood, non un singolo artista ma un gruppo proveniente dal Canada e in circolazione ormai da una dozzina abbondante di stagioni, le sgocciolature — il confuso intrecciarsi di litanie folk, scatti punk e deliberati stravolgimenti country — si inseguono all’apparenza assecondando un imprevedibile margine di casualità. Eppure, alla fine, il risultato sembra sempre in qualche modo organico, forse persino coerente rispetto all’idea di un alt.country dove il respiro della tradizione s’intrecci a repentini sconfinamenti elettrici.
Merito di un gesto artistico nel quale naturalezza e irruenza sostituiscono il montaggio delle suggestioni, rendendolo invisibile e trasformando la sovrapposizione tra radici e loro rielaborazione in un’unica realtà: in questo, e cioè nel proporre il personale slancio alla stregua della costruzione di un nuovo linguaggio, imprimendogli forza, emozione e intensità, gli Elliott Brood — Mark Sasso, Casey Laforet e Stephen Pitkin — si dimostrano ancora una volta talentuosi e disinvolti.
Ciò nonostante, al sesto album la formula del gruppo inizia a mostrare qualche crepa, perché se Ghost Gardens parte alla grande, sganciando in forma di bombardamento sensoriale il furioso rockabilly semiacustico di ’Til The Sun Comes Up Again, il folk-punk aggressivo della ruvida Dig A Little Hole, il country-rock di una febbricitante Gentle Temper (sulla scia del primo Ryan Adams solista) e soprattutto la biblica tempesta di chitarre di una 2 4 6 8 da qualche parte tra i Clash e i riff di banjo di un’oscura famiglia degli Appalachi, il resto del programma si raggomitola presto in una serie di tiepide ballate folkie dominate dall’incertezza e dalla prevedibilità.
Certo, le carezze d’altri tempi della raccolta Adeline o le armonie quasi beatlesiane della poppeggiante The Widower possono incuriosire al primo ascolto, ma davvero non sembrano in grado di suscitare il benché minimo interesse in quelli successivi. Lo stesso discorso vale per il mandolino dell’intimista, conclusiva For The Girl: irreprensibile, sì, peccato però arrivi dopo i rumori sconclusionati dell’insulsa Searching, la saturazione di riverbero dell’altrettanto inconcludente The Fall o l’afasia strumentale di una raccogliticcia T.S. Armstrong, brano che non si capisce se voglia essere per forza scontroso oppure sia, semplicemente, poco ispirato.
Forse il problema di Ghost Gardens riguarda l’assenza di un trait-d’union forte tra le diverse tracce, elemento invece preponderante in Days Into Years (2011), un lustro abbondante fa dedicato alla memoria della Prima Guerra Mondiale, o nel penultimo Work And Love (2014), tre anni or sono deputato a raccogliere un po’ tutti i linguaggi del country cosiddetto alternativo come l’abbiamo conosciuto dai Whiskeytown in poi.
È vero, il Canada, così come l’America, è vasto e denso, ma frequentando le frattaglie varie di Ghost Gardens rimane addosso la delusione di averne visto un pezzo solo e nemmeno troppo evocativo. Niente di male, per carità, anche se le testimonianze più autentiche, del fascino del Canada e delle qualità degli Elliott Brood, stanno altrove.