

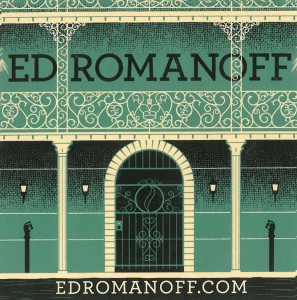 ED ROMANOFF
ED ROMANOFF
Ed Romanoff
autoprodotto
***½
Questo album racconta la storia di una vocazione, e di una scoperta, entrambe tardive. La scoperta è quella di chi scrive, ignaro dell’esistenza del disco (targato 2012) fino a pochi giorni fa, quando le due date italiane di Ed Romanoff, in apertura ai concerti di Rachael Yamagata (potrete leggere l’intervista sul numero di novembre), mi hanno dato la possibilità di approfondirne il lavoro. La vocazione, invece, è quella dell’artista stesso, per anni impegnato nel campo della comunicazione e debuttante come titolare di questa opera prima e omonima solo all’età di 53 anni.
La storia artistica di Romanoff, difatti, inizia alla fine degli anni ’90, dopo un incontro casuale con Mary Gauthier: i due siedono nello stesso ristorante, in tavoli attigui ma separati, e intavolano un discorso per riempire il momentaneo vuoto creato dalla distrazione del commensale di lei, scoprendo un interesse comune per la letteratura, la musica e la capacità di sposarle attraverso lo storytelling della canzone d’autore. Come racconta Romanoff nelle note di copertina, i due diventano amici e, nel 2010, entrambi reduci da un test del DNA (Romanoff aveva accompagnato la musicista, orfana dalla nascita, e, per farle coraggio, si era a sua volta sottoposto alla verifica, apprendendo con stupore di essere anche lui adottato e non di discendenza russa, come aveva sempre creduto, bensì irlandese), scrivono un brano a quattro mani – The Orphan King – per il sesto album della Gauthier, l’autobiografico The Foundling.
Ispirato dal lavoro della conoscente e dall’essere entrato in contatto con il suo produttore dell’epoca, Michael Timmins (Cowboy Junkies), Romanoff decide di provare a reinventarsi cantautore. Il primo risultato – un secondo disco è atteso tra la fine del 2015 e l’inizio dell’anno prossimo – porta il suo nome e, a conferma della bontà e della forza espressiva di una scrittura già gratificata da numerosi riconoscimenti (compresa la vittoria del prestigioso Kerrville Folk Festival nel 2013), vede schierati diversi collaboratori eccellenti, dalla citata Gauthier (naturalmente) al collega Josh Ritter (co-autore di varie tracce), dall’ex-batterista dei Fairport Convention Dave Mattacks (dietro i tamburi lungo tutto il disco) al chitarrista Duke Levine, senza dimenticare le voci, il fascino e le armonizzazioni di altre complici quali Tift Merritt e Meg Hutchinson.
Ed Romanoff – l’album – merita una segnalazione in virtù dello stile felpato, minimalista e d’altri tempi del suo artefice, in possesso di un timbro subito simile a quello ruvido di un Robert Earl Keen e di un istinto per la composizione dove s’intrecciano gli amori di una vita per Bob Dylan e John Prine, evidentissimi, per esempio, nel folk umanista della divertita Potholes. Un altro punto di riferimento di Romanoff è il Mark Knopfler solista, nello specifico la sua capacità di tradurre le radici della musica americana in piccoli romanzi sonori costruiti sul suono nostalgico degli archi e la poesia asciutta delle sei corde: è grazie a questa attitudine descrittiva, finemente malinconica, se i brani del disco si trasformano in una successione di quadri o storie brevi nella quale spuntano sofferte ballate rock (su tutte St. Vincent De Paul e Breakfast For One On The 5th Of July, i due episodi migliori), cauti e ironici esercizi di impressionismo rootsy (Two Yellow Roses, Lady Luck), incisivi affreschi pianistici alla John Hiatt (Sacred Wreck), cartoline da New Orleans (I Must Have Done Something Right) e deliziosi omaggi al passato (ci si congeda con una rilettura della I Fall To Pieces di Harlan Howard e Hank Cochran, portata al successo da Patsy Cline nel 1961, degna delle atmosfere di Joe Henry).
L’album, supervisionato dall’esperto Crit Harmon, scorre lieve pur trattando temi molto seri e spesso dolorosi, e rende pubblico il magnetismo, il talento e l’ispirazione di Ed Romanoff, modesto e misurato per costituzione ma in possesso di un mestiere senz’altro più solido di quello di tanti suoi (incensati) colleghi. Per raccontare in musica le azioni e l’intensità delle emozioni, evidentemente, non è mai troppo tardi.