

MEMORIE DALLA QUARANTENA
Devo ammettere di trovarmi in una situazione molto privilegiata rispetto ad altri costretti in clausura forzata dal dannato virus. Da tanti anni vivo all’estero, ormai da molto tempo in una zona di campagna dove il verde sembra dipinto coi colori a olio e le mucche ti guardano con lo sguardo di chi in quei pascoli ha trovato il senso della vita. La Svizzera Interna, quella parte del paese dove la gente abbaia un dialetto che suona come il tedesco di montagna (lo Schwiizertütsch), è uno di quei luoghi dove vivere l’isolamento è simile a come doveva essere la giornata di un boss mafioso in Italia prima dell’introduzione del 41 bis. Non ci vuole nessuna autocertificazione; non s’incontrano posti di blocco; il comportamento dei singoli (distanziamento, uscite, sport all’aria aperta, etc) è demandato al senso civico degli abitanti che qui è tatuato nella testa e nel cuore di ognuno.
Faccio un esempio. Dalle mie parti, se uno vuole comprare del formaggio e non vuole arrivare fino al supermercato, basta che si rivolga al contadino più vicino che mette a disposizione di chiunque la sua selezione di latticini in bella mostra nel frigo della sua cascina; accanto al frigo sta un cestino dove immancabilmente il cliente lascerà il contante dovuto per l’acquisto. Perché non esistono i Furbetti nella terra di Guglielmo Tell. Lo stesso vale per frutta, verdura, conserve e affini. Se poi si volessero prendere dei fiori da regalare alla propria Bella o per allietare la casa, basterebbe andare nel campo dello stesso contadino dove si potranno recidere i fiori direttamente dalle piante (le forbici sono gentilemente offerte) e lasciare il denaro nell’apposita cassettina. Non sorprenderà quindi che, ben prima dell’epidemia, gli svizzeri avessero pensato a luoghi gestiti dalla comunità locale per la comunità (qui il bene comune è Vangelo) dove è possibile prendere a prestito libri e persino dischi. E mica soltanto quegli oggettini di forma rotonda fatti di policarbonato con qui librettuncoli scritti in caratteri illeggibile che non ho mai frequentato e credo si chiamino compact disc; in quelle biblio-discoteche si trovano proprio i vecchi-ora-di-nuovo-di-moda vinili. E se per caso uno cercasse un certo disco che non fosse momentaneamente disponibile in loco, il circuito delle biblioteche svizzere si mobiliterà in tempo reale per rendere accessibile il desiderato ellepì nel giro di ventiquattr’ore. Che Spotify ci fa un baffo a noi!
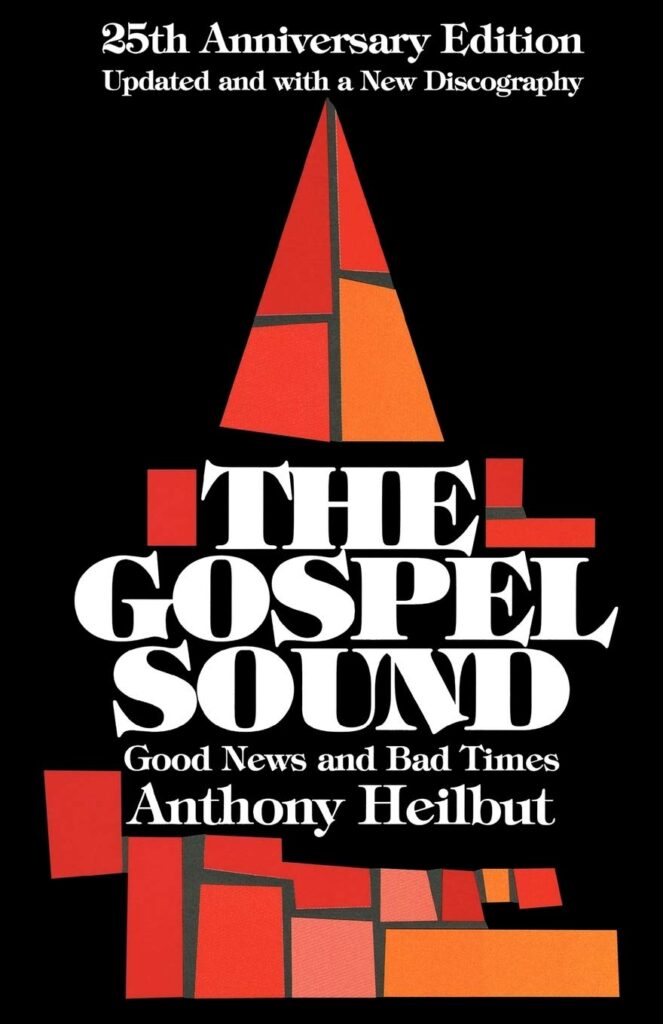
Per me costretto in isolamento questa è la manna, perché purtroppo tutti i miei dischi sono rimasti in Italia, così come gran parte dei libri, soprattutto quelli di musica. Così grazie al servizio cantonale di Svitto, ho ripreso in mano “The Gospel Sound” di Anthony Heilbut, un libro che tanti anni fa mi era stato consigliato dal Maestro di Musica Religiosa Gianni Del Savio. Heilbut, figlio di ebrei tedeschi rifugiati in America, è stato professore universitario e soprattutto produttore di gente come Mahalia Jackson e Marion Williams, prima di lanciare l’etichetta Spirit Feel, ovviamente dedicata al gospel. Adoro la sua affermazione: ”non bisogna essere credenti per amare la musica del Signore”, Heilbut è ateo dichiarato. Grazie a quel libro ho fatto un passettino verso il Paradiso, pur nella mia scarsa conoscenza della musica sacra. A parte i nomi conosciuti al di fuori della ristretta cerchia degli amanti del genere (Mahalia, Marion, Sister Rosetta, Staple Singers, Soul Stirrers), ve ne segnalo quattro che mi hanno colpito particolarmente.
Prima di tutto Bessie Griffin, vero nome Arlette Broil, contralto dalla voce possente e dalla straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico. Venne scoperta da Mahalia Jackson a cui si dice rubò la scena di fronte a più di 40,000 persone. Per la sua comunicativa schietta e travolgente apparve spesso in televisione e fu invitata ad esibirsi anche nel Vecchio Continente: Negro Spirituals, Gospel Songs – Live In Europe (FRA Carrere) è un album travolgente che la ritrae dal vivo in Francia nel 1979. Le Caravans furono uno dei gruppi di gospel più influenti fra gli anni 50 e 60. Fondati a Chicago da Albertina Walker, videro avvicendarsi soliste del calibro di Bessie Griffin, Cassietta George, Inez Andrews, Dorothy Norwood e Shirley Caesar, oltre che un pianista e compositore come il Reverendo Cleveland. Nella mia discoteca vicino casa ho avuto modo di prendere in prestito due album significativi: Mary Don’t You Weep (Gospel) del 1959 con la Andrews solista, e The Best Of Shirley Caesar with The Caravans (Savoy) del 1966 con la straordinaria cantante predicatrice della North Carolina. Clara Ward, con mamma Gertrude e sorella Willa (le Ward Singers), è stata per anni la Signora del canto religioso di Philadelphia ed ha rappresentato l’incubatrice del dinamismo di Marion Williams e l’ispirazione per una giovane Aretha Franklin. Tutto il periodo Savoy è eccellente, con brani come How I Got Over, The Day Is Past And Gone e Come On In The Room.

L’ultima segnalazione è assolutamente dovuta per uno dei maggiori gruppi gospel della storia, i Dixie Hummingbirds, fondati nel 1928 in South Carolina. Difficile scegliere fra le registrazioni a cappella per etichette come Apollo, Gotham e OkEh; oppure quelle del periodo Peacock dove vengono accompagnati da una sezione ritmica. Suggerisco due classici, Nobody Knows The Trouble I’ve Seen e You’ve Got To Live, giusto come assaggio. Per chiudere il cerchio, se non l’avete ancora fatto, andatevi assolutamente a vedere uno dei più indimenticabili documentari musicali mai visti, “Amazing Grace” di Aretha, diretto nel 1972 da un giovanissimo Sydney Pollack (“Non Si Uccidono Così Anche I Cavalli”, “Corvo Rosso”, “Come Eravamo”, etc), che si credeva perduto e che invece ha visto la luce del sole due anni fa. Girato nella chiesa di Watts, South Los Angeles, del Reverendo Cleveland, il film coglie il trasporto e l’estasi che solo la musica del Signore possono portare ad una comunità afroamericana. Consiglio: non prendete i fazzoletti, portatevi UN ASCIUGAMANO, perché non riuscirete a fermare la commozione!!!
E siccome “le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”, dopo aver percorso le strade del Signore col gospel, gli ascolti della quarantena mi hanno portato in territori meno virtuosi. Per la serie “Il Diavolo e L’Acqua Santa”, vi propongo un salto mortale di genere musicale. Lo sapevate che con ogni probabilità fu Zappa a usare per primo il temine punk in musica nel suo sfottò del sogno hippie sul brano Flower Punk; poi Lenny Kaye se ne appropriò nelle note di Nuggets per descrivere l’attitudine delle garage bands tipo 13th Floor e Seeds? Devo ammettere di essere venuto grande col punk dei 70. Non tanto quello della Perfida Albione (Pistols, Clash e Damned). No, la mia fulminazione sulla via di Damasco avvenne con l’ascolto di Horses di Patti Smith, che mi cambiò la vita! E così il mio cuore è rimasto legato alle avanguardie di Oltre Oceano. La scena della Bowery di New York mi rapì per la sua diversità: dove trovate una culla di creatività da cui nacquero gemelli diversi come Ramones, Television, Talking Heads, Blondie e Richard Hell? Poi scoprii la San Francisco di Avengers e Dead Kennedys, la Los Angeles di X e Germs, la Cleveland di Pagans, Pere Ubu, electric eels, e le tante altre città della provincia americana. Se ci fosse qualche lettore del Busca curioso di approfondire quel genere, poco frequentato sulla nostra rivista, e interessato a scoprire quella massa di minori-non-minori che avrebbero potuti essere (quasi) famosi per lo spazio di un singolo (perché il formato del punk è il 45 giri), consiglio le raccolte Killed By Death. Ci vorrebbe un articolo per raccontarne la storia.
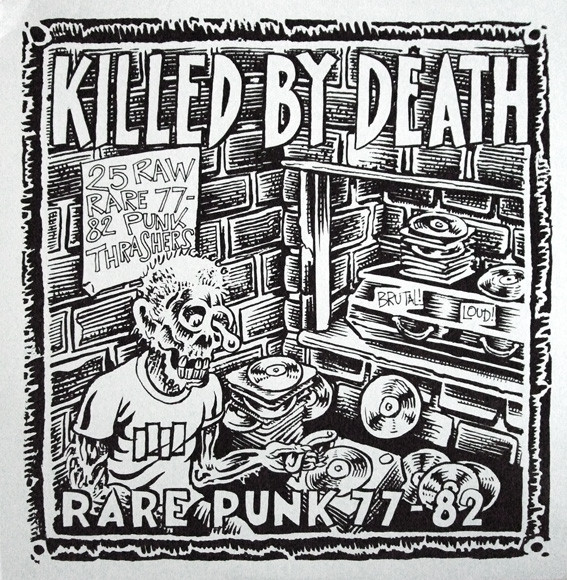
In epoca pre-internet, soprattutto dopo l’uscita dei CD, l’America pullulava di vinili sconosciuti, spesso stampe private, che però rimanevano confinati negli stati dove erano stati prodotti. Fu così che appassionati e collezionisti s’inventarono dei modi creativi per allargare le proprie conoscenze. Per esempio nell’ambito della psichedelia anni 60-70, Paul Major mise in piedi una vera e propria rete di gente malata della stessa musica che funzionava così: “tu che vivi in Ohio, manda a me che vivo a New York una copia di ogni ellepì uscito non su etichetta major nel tuo stato che contenga assoli di chitarra fuzz, testi visionari, magari con riferimenti a droga; io farò lo stesso coi dischi dello stato di NY e limitrofi. L’unica regola è: più sono strani (suoni e copertina) e meglio è!”. Poi Paul selezionava la quantità di roba che riceveva da ogni lato del paese e condensava le sue scoperte in cataloghi che spediva ad appassionati europei, giapponesi, australiani, in cui enfatizzava le doti di ciascun gruppo e vendeva per corrispondenza le sue scoperte facendole conoscere nei 5 continenti. Nel punk lo stesso ruolo, una decina di anni dopo, fu svolto da Chuck Warner che appena fuori Boston assemblava e catalogava una massa di rarità, spesso a formato 45 giri, punk/new wave/DIY che poi raggruppava in cataloghi divenuti vere e proprie Bibbie per noi fanatici oltre Oceano. Poi un giorno, attorno al 1988 un appassionato svedese a nome Johan Kugelberg, ispirato dalla serie Back From The Grave di Tim Warren sul garage anni 60, decise di investire quattro corone e di bootlegare delle compilazioni che raccogliessero brani punk da tutto il mondo provenienti dalla sua collezione. Ne fece uscire quattro di quei volumi in due anni: era nato il fenomeno “Killed By Death”!
Quei dischi pirata erano pensati come strumento per far conoscere ai pochi appassionati del genere alcune pepite punk ancora nascoste nella roccia. Dopo Johan, il progetto KBD fu portato avanti da un noto collezionista australiano, poi da un americano, infine da molti altri che mantennero lo spirito anarchico, la denominazione della collana e l’etichetta tarocca (Redrum). E dal 1988 al 1999 ne uscirono più di 30 volumi!!! Ancora oggi, a meno che non siate i rampolli di una ricca famiglia e possiate permettervi di sborsare qualche centinaio di dollari a singolo per un originale, quei volumi rappreseno il modo migliore per scoprire piccoli gioielli minori. Qualche suggerimento d’ascolto? Ecco a voi: Muff Drivin’ (Gizmos), Just Head (Nervous Eaters), Taking The City By Storm (Haskels), Almost Ready (Normals) e Band-Aid (Trend). E potrei continuare per ore.

In realtà molte di quelle band accaddero in quella zona d’ombra, quella fase di passaggio fra i gruppi garage catturati da Lenny Kaye in Nuggets e i fermenti successivi: il cosiddetto proto-punk. Anche qui ci vorrebbe almeno un articolo per raccontare le gesta di formazioni note (Modern Lovers, Suicide, Chrome) e altre semi-sconosciute (Debris, MX-80 Sound, Simply Saucer). E a proposito di prime movers, di primi agitatori di una scena, in questi giorni mi sono fatto una grande abbuffata di un gruppo di Boston, fondamentale quasi come i Modern Lovers, che recentemente è stato oggetto di una serie di pubblicazioni inedite. Si tratta dei Real Kids, a cui la Crypt di Tim Warren ha dedicato ben quattro uscite su formato ellepì. Nel 1970 John Felice, allora quindicenne, si unì al suo compagno di merende Jonathan Richman. Dopo poco però, stanco del perfezionismo paranoico del suo amico, decise di mettere su la sua band, che prima prese il nome di Children’s Rock’n’Roll Band (visto che l’età media dei componenti era 13 anni), poi Kids e infine Real Kids. Nel frattempo Felice era stato contattato da Johnny Thunders per entrare nella prima formazione degli Heartbreakers (quella con Richard Hell), ma saggiamente decise di chiamarsi fuori dopo uno sciagurato weekend di sballo a base d’eroina. Nel 1977 i Real Kids pubblicarono un album fondamentale su etichetta Red Star di Marty Thau, la stessa che diede alle stampe il primo lavoro dei Suicide. Delle recenti uscite postume (due live, una in studio e una mista), consiglio l’assaggio del pezzo Taxi Boys dai demo del novembre del 1974 dei Kids, e dell’immortale inno alle donne All Kindsa Girls dal vivo al Rat’s del gennaio 1978.
Rimanendo a Boston e alla Crypt, un altro disco che in questo periodo gira spesso sul mio giradischi è il live dei Lyres del settembre 1980 che coglie la band di Jeff “Mono Mann” Conolly nella sua fase di passaggio appena successiva ai DMZ e pochi mesi dopo la pubblicazione del loro primo singolo. Arricchiti dalla presenza di Peter Greenberg, appena tornato a casa dopo l’esperienza a Cincinnati, Ohio coi Customs (autori di due singoli), i quattro fanno letteralmente a pezzi il pubblico col loro rock’n’roll stradaiolo. Ascoltare Long Gone oppure la loro versione di Louie Louie per crederci.

Se vi dicessi che Chris Whitley è stato il più grande cantautore americano degli anni 90, cosa mi rispondereste? Se non lui, chi altro? La sua carriera partì col botto: scoperto da Daniel Lanois nel 1988, lanciato da una major, nientepopodimeno che la Columbia, etichettato come il nuovo Springsteen, invitato ad aprire i tour di Dylan e Tom Petty. Sembrava un predestinato! Invece sbagliò la deviazione, oppure la prese a bella posta, e si ritrovò a Lostburg, il paese della perdizione, la capitale della bevuta, il palcoscenico dell’estasi (per un paio d’ore) e del tormento (per il resto della giornata). La sua vita si trovò spesso ad essere sospesa ai confini dell’allucinazione, costretto allo stordimento della coscienza da cui rinveniva per assecondare il suo genio e comporre pagine di musica indimenticabile armato della sua chitarra National. Mi spingerei a dire che Chris sia stato colui che in tempi recenti più si avvicinò a ripetere il patto col Diavolo, lo stesso che Robert Johnson strinse sessant’anni prima. Prese la materia del blues, ci lavorò per sottrazione scarnificandola, e su quello scheletro agganciò le sue liriche e costruì le sue canzoni.
Io sono particolarmente legato al suo lavoro acustico del 1998, Dirt Floor (Messenger 04), un assoluto capolavoro. Registrato su un vecchio registratore a bobine nell’arco di una sola giornata nel fienile vicino casa del padre in Vermont, solo con la sua resofonica (raramente il banjo) e quella voce: fragile e tirata fino a sfiorare il punto di rottura, sofferta e dolente. Ascoltate quella fotografia sgranata e dai toni seppia che si chiama Scrapyard Lullaby, o ancora Wild Country che suona come inno alla vita semplice della provincia americana lontano dalle luci della ribalta. Due anni dopo volle incidere un album per rappresentare e rileggere i suoi modelli di riferimento ed ispirazione. Perfect Day (Valley Entertainment 15119) è un meraviglioso disco di covers, in trio con contrabbasso e percussioni, che inanella uno dietro l’altro lo spirito di Robert Johnson, Muddy Waters, Willie Dixon, Jim Morrison, Bob Dylan, Lou Reed fra gli altri: She’s Alright, disseziona e ricompone il vecchio blues di Muddy; la title song aggiunge un elemento onirico alla canzone d’amore per eccellenza; Spoonful trasporta il classico di Dixon in una zona d’ombra, a sottolineare il tema della dipendenza che si nasconde nel testo. Poi, improvvisamente, come in tutte le storie di perdizione che si rispettino, uno dei suo molti vizi lo tradì ancora giovane: morì di un tumore ai polmoni fulminante a 45 anni il 20 novembre 2005.

Proprio ieri nella biblio-discoteca vicino casa ho preso in prestito un ellepì appena uscito a cui sono riuscito a dare solo un paio d’ascolti ma che mi permetto di consigliare. Trattasi di Oneiric Formulary (Drag City 769) di Sir Richard Bishop. Richard ha una lunga storia alle spalle. I suoi Sun City Girls, il gruppo formato col fratello Alan, hanno terremotato l’America per tutti gli anni 80 e 90 con scosse di magnitudo 8 sulla scala Richter della sperimentazione. Nei suoi dischi solisti si è rivelato uno dei migliori chitarristi acustici contemporanei. In quest’ultimo lavoro veniamo catapultati nel solito caleidoscopio di influenze e generi, dalla lounge music jazzata di Mit’s Linctus Codeine Co., al raga indiano di Renaissance Nod, fino ai suoni primitivi americani di Enville. E questa volta lo strumento principe non è solo l’acustica, ma anche la sei corde elettrica, tastiere, rumori ed effetti vari.
Al di là della musica e delle letture, anche qui come nel resto del mondo le giornate sono punteggiate dalle notizie e dalle discussioni legate alla pandemia. In Svizzera la Presidentessa della Confederazione Simonetta Sommaruga ha condiviso già da alcuni giorni il percorso a tappe successive per un ritorno a una quasi-normalità del paese. Il Governo si è dato la priorità assoluta di rendere disponibili i fondi previsti per la ripartenza economica con la massima celerità attraverso meccanismi semplificati, e di allargare le misure a tutte quelle categorie di persone e imprese che ne abbiano la necessità. La riflessione politica si sta concentrando sui cambiamenti necessari che la crisi corona virus ci impone a livello di scelte energetiche, sanitarie e soprattutto sociali per evitare che le disparità economiche, già significative prima dell’epidemia, si accentuino fino a raggiungere un punto di non ritorno. È un’opportunità unica a livello pubblico e privato per chiunque voglia ripensare all’implicazioni della crisi, riconsiderare la propria vita e il proprio paese e ricostruirli su basi più sostenibili ed eque. E vengono in mente le parole di Italo Calvino premonitrici e ispiratrici: “Vedevam l’altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre al ponte”.